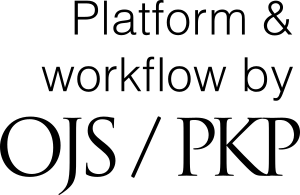PTH – Performative Thinking in Humanities / 1
Un Quaderno periodico
DOI:
https://doi.org/10.6093/2284-0184/7711Abstract
Rosario Diana
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPF-CNR)
rosariodiana61@gmail.com
Editoriale
Performative Thinking in Humanities
Un Quaderno periodico
Editoriale in cui si spiega che il Quaderno Think Tank PTH – Performative Thinking in Humanities diventerà una pubblicazione annuale dedicata alla disseminazione dei saperi filosofici e umanistici attraverso le arti audiovisive e musicali.
Filosofia, Musica, Teatro, Impegno, Politica
Fabrizio Masucci
Museo Cappella Sansevero
fabriziomasucci@museosansevero.it
Un melologo filosofico per Raimondo di Sangro principe di Sansevero
Prefazione del Presidente del Museo Cappella Sansevero al libretto e alla partitura del melologo.
Velo, Cristo velato, Museo Cappella Sansevero, Teatro della Filosofia, Disseminazione
Rosario Diana
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPF-CNR)
rosariodiana61@gmail.com
Il pensiero velato
Una meditazione notturna del principe di Sansevero
melologo in quattro quadri per voce recitante, voci registrate e percussioni
libretto
Basato sulle opere di Raimondo di Sangro e su altri testi dell’epoca concepiti nella cerchia dei cosiddetti Liberi pensatori, il libretto mette a fuoco la personalità del principe di Sansevero nel momento in cui scrive la Supplica (1753) da inviare a Benedetto XIV per chiedergli di derubricare la sua Lettera apologetica (1751) dall’Index librorum prohibitorum. Raimondo di Sangro viene presentato come un ostinato difensore della libertà di pensiero e della tolleranza. Il suo interesse per il sistema di segni del popolo peruviano (quipu) denuncia in lui un’attenzione per la scrittura, intesa come l’unico strumento concesso all’uomo per lasciare traccia di sé e guadagnare quindi una immortalità (non personale) nella fama.
Pensiero critico, Tolleranza, Censura, Scrittura, Sperimentazione
Rosalba Quindici
Hochschule der Künste Bern
rosalbaquindici@yahoo.it
Il pensiero velato
Una meditazione notturna del principe di Sansevero
melologo in quattro quadri per voce recitante, voci registrate e percussioni
score
Partitura musicale del melologo.
Musica contemporanea, Ricerca timbrica, Percussioni, Scrittura, Sperimentazione
Rosario Diana
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPF-CNR)
rosariodiana61@gmail.com
Pandemia 2020 / scena deserta
Breve storia di un progetto nato e mutato dall’emergenza sanitaria
Il breve saggio racconta le fasi di lavorazione necessarie a produrre il video Pandemia 2020 / scena deserta, che evoca il tema dei teatri chiusi per la l’epidemia di Covid-19 ed è dedicato ad attori e musicisti in difficoltà perché rimasti senza lavoro. L’esplodere dell’emergenza sanitaria ha costretto i partecipanti a modificare il progetto mentre era in corso di svolgimento.
Teatro, Video, Scenografia, Musica, Sceneggiatura
Nera Prota
Accademia di Belle Arti di Napoli
nera.prota@yahoo.com
Pensare con le mani nell’era digitale
Manualità tra Information Technologies (IT) e creatività umana
Nelle Accademie di Belle Arti, sempre più spesso l’information technology è proposta come un sostituto o un surrogato dello sviluppo individuale della manualità. Coloro i quali, per qualsiasi motivo, si sentono a disagio nell’usare la loro manualità, possono trovare un’apparente via di uscita nell’uso dei software. Tuttavia, questo trend rinforza la perdita di manualità impedendo alle persone di costruire un loro personale linguaggio artistico. L’aiuto delle macchine nella produzione artistica incontra un’esigenza di mercato, consolidando l’idea fittizia che la creatività umana possa essere espressa attraverso processi standardizzati. Certamente, ciò è funzionale all’interesse del mercato. Per esempio, uno dei software più usati in ambito artistico progettuale è il CAD (Computer-aided design). Il nome del software immediatamente svela la relazione asimmetrica con l’utente. In molti casi, software come il CAD possono interagire direttamente con altre macchine complesse (ossia macchine a controllo numerico) per intraprendere attività di larga scala ed estrema precisione. In questo saggio, l’autrice ricerca il confine tra la produzione industriale e la creatività umana in ambito artistico, sfatando in questo modo alcune ambiguità sul ruolo che la tecnologia ricopre nella società.
Design, Virtuale, Arte, Tecnologia, Didattica
Benedetta Tramontano
Accademia di Belle Arti di Napoli
bene_98@hotmail.it
Ricerca stilistica e scelte personali
Tecla: un’evocazione visuale in tre bozzetti di una città invisibile di Italo Calvino
Nel contributo si descrivono le modalità seguite nel dare una raffigurazione fantastica – dunque soggettivo-prospettica – di una delle città invisibili di Italo Calvino: Tecla, la metropoli-cantiere. L’Autrice ha deliberatamente scelto il disegno e la colorazione a mano libera, rifiutandosi di utilizzare software di disegno digitale.
Acquerello, china, bozzetto, colore, disegno digitale
Rosario Diana
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPF-CNR)
rosariodiana61@gmail.it
Giancarlo Turaccio
Conservatorio Statale di Musica di Salerno “Antonio Martucci”
giancarlo.turaccio@gmail.com
Un ascolto iniziatico
Conversazione tra un filosofo e un compositore sulla musica acusmatica
Un ricercatore di filosofia e un docente di composizione dialogano sulla musica acusmatica, ossia quella proposta (anche in concerto) in assenza della sua fonte sonora. La discussione ricostruisce brevemente la storia del concetto e mette in evidenza l’importanza dell’ascolto “puro”, fondato sulla relazione diretta fra l’orecchio e l’oggetto sonoro.
Pitagorici, Pierre Schaeffer, Walter Benjamin, Oggetto sonoro, Spazializzazione del suono
Gianvincenzo Cresta
Conservatorio Statale di Musica di Avellino “Domenico Cimarosa”
gianvincenzo.cresta@conservatoriocimarosa.org
Ricordo di Bruno Maderna (1920-1973) a cento anni dalla nascita
Del canto immobile
Qualche riflessione su Per Caterina di Bruno Maderna per violino e pianoforte
Spesso nell’indagine storico analitica su un compositore si cerca una sintesi e ci si focalizza su alcune opere ritenendole maggiormente rappresentative. È una via possibile che però delimita l’identità del compositore, piegandolo a una narrazione semplificata, mentre invece il cammino creativo di un artista è un complesso caleidoscopio. Per Caterina di Bruno Maderna è un breve brano per violino e pianoforte composto nel 1963, il cui esito, pur ponendosi in rottura rispetto ad altre sue opere e agli stilemi stilistici degli anni ’50 e ’60, si colloca con naturalezza nell’arco creativo dell’autore. È un brano emblematico del suo modo di vivere la musica come fenomeno unitario, senza steccati stilistici e categorizzazioni. La retorica è per Maderna un mezzo e non un’estetica e la musica un’esperienza complessa che mescola al sonoro il percettivo, il motorio e l’emozionale. Afferma Maderna: «la musica non può essere che un fatto espressivo, un suono suscita reazioni e i suoni non sono che mezzi».
Identità, Canto, Antico, Modernità, Libertà
Tommaso Rossi
Conservatorio Statale di Musica di Benevento “Nicola Sala”
info@tommasorossi.it
Una grande Aulodìa
Flauto e oboe nella “melodia arcaica” di Bruno Maderna
Nella variegata e copiosa produzione musicale di Bruno Maderna la scelta di dedicare una particolare attenzione al flauto e all’oboe – i due più acuti rappresentanti della famiglia dei “legni” – sembra andare oltre il pur comprensibile interesse del compositore per l’indagine timbrica di due affascinanti strumenti, ma è legato a ragioni più profonde, che risiedono in aspetti fondanti della poetica musicale del compositore. Il flauto e l’oboe sono “gli” strumenti della mitologia classica, e il loro suono particolare rimanda immediatamente alla Grecia antica, alla civiltà che il popolo greco ha creato e al culto della bellezza che ne è scaturito, influenzando il corso della storia dell’Occidente. Maderna guarda, attraverso il suono di questi strumenti, a questo mondo – oggi perduto – con il preciso desiderio di riproporre utopicamente, in una modernità segnata dalla violenza delle macchine e nel contesto di una società disumanizzata, un ideale superiore ma irraggiungibile di armonia. Attraverso l’analisi di molti dei lavori scritti da Maderna, che hanno per protagonisti il flauto e l’oboe, l’autore ricostruisce alcuni aspetti dell’estetica maderniana.
Hyperion, Musica su due dimensioni, Grande Aulodia, Don Perlimplìn, Terzo concerto per oboe
Rossella Gaglione
Università degli Studi di Napoli Federico II
rossellagaglione@hotmail.com
Discorsi tra Eco e Narciso
A proposito di un recente libro di Dario Giugliano
Che rapporto c’è tra ίδιος e κοινός? E come possono la filosofia (nello specifico la metafisica) e la letteratura coniugare questi due termini? Quanto è difficile, e allo stesso tempo necessario, comunicare con l’Altro, cioè trasferire la propria voce singolare all’interno del sistema segnico condiviso affinché possa essere compresa? Che cos’è l’esperienza? Cosa si intende per idiotismo? Com’è possibile leggere il mito di Eco e Narciso? Questi e altri interrogativi sono alla base del testo di Giugliano che – grazie anche al confronto con vari pensatori (tra cui Platone, Novalis e Nietzsche) – offre numerosi e interessanti spunti di riflessione.
Idiotismo, comunicazione, esperienza, Filosofia, linguaggio
Downloads
##submission.downloads##
Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).