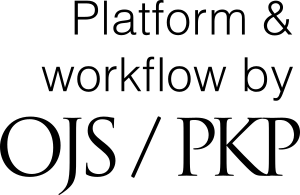CITTÀ - PORTO - MARE I caratteri evolutivi di un rapporto complesso
DOI:
https://doi.org/10.6092/2281-4574/2211Parole chiave:
città, porto, mareAbstract
L’equilibrato rapporto tra città e mare fu alla prioritaria attenzione del pensiero greco, in particolare di Platone, che nel pieno fiorire della civiltà ellenica si interrogò su quali caratteri dovesse avere il sito per accogliere confortevolmente un insediamento urbano in prossimità del mare.
Ne derivò un idealtipo di modello insediativo urbano fondato su presupposti di “accessibilità”, di “sicurezza”, di “igienicità”, di “produttività”, di “prossimità” a fonti energetiche e di“prosperità”.
Gli artisti rinascimentali attingono alle fonti del sapere antico per dar vita ad un rinnovo della trattatistica architettonica ed urbanistica idealmente indirizzata alla costruzione di nuovi modelli tesi a perfezionare, attraverso la forma, rigorosamente geometrica, la struttura e l’anima della città.
Ragioni di sicurezza e di salvaguardia della salute allontanavano la città dal mare, favorendone la ubicazione in siti più confortevoli, su altipiani o nelle compagini di sistemi collinari di misurata acclività, ben distanti dagli approdi costieri e dai porti naturali fasciati da territori impaludati esposti alle infestazioni malariche, la cui desertificazione era interrotta dagli episodici e primordiali insediamenti delle piccole comunità di pescatori.
Il porto nasce con le braccia aperte, divaricate in direzione del mare; un abbraccio teso a manifestare il piacere dell’incontro, a garantire riparo, protezione, sicurezza ed amicale accoglienza. Volge viceversa le spalle alla città, talvolta allontanandola anche considerevolmente da sé, una misura tesa a ”mantenere le distanze”, quasi ad assumere un atteggiamento altezzoso, improntato a manifesta rivalità competitiva, impedendole di procedere oltre, di valicare il limite del dovuto, investendo spazi destinati ad altro, a scandire specificazioni e diversificazioni di ruoli, mansioni ed attività professabili.
Barriere fisiche ed istituzionali si frappongono tra città e mare rivendicando autonomi ruoli politico amministrativi e pianificatori che spesso finiscono con l’ostacolare anziché favorire i naturali processi osmotici, svilendo di significato funzioni, ruoli ed interessi sociali, economici, politici e culturali di reciproca appartenenza.
Il porto e la città hanno come comune denominatore il mercato, il luogo dell’incontro, dello scambio di prodotti, idee, credenze fideistiche, costumanze, consuetudini, tradizioni, conoscenze, culture e civiltà. Il primo si configura come l’anticamera della seconda; i suoi spazi sono di transizione contro quelli di sosta e permanenza anche definitiva dell’altra.
L’evoluzione legislativa ha quasi ovunque seguito e non preceduto la devastazione territoriale degli insediamenti lungo i litorali, specie quella “spontaneamente” andatasi a determinare, e solo tardivamente ha preso a porre argini ad un fenomeno rientrato tristemente nelle costumanze dell’ “operare” nei vuoti del “pensare”, lasciando che la consuetudine al “fare” prevalesse sulla legislazione conservativa fondata sul porre picchetti al “non fare”; il tutto all’ombra o, peggio ancora, alla luce di un potentato economico erettosi a regista del potentato politico, condizionato ad aprire gli occhi sul “fare” per socchiuderli sull’”affare” .
Il nuovo rapporto città-mare va studiato in termini “valorizzativi”, non certo limitabili alle sole misure cautelative prescritte dagli strumenti di pianificazione ordinaria, paesistica ed urbanistica , o agli interventi progettuali interessanti il rinnovo estetico delle palazzate di fronte mare ; occorre procedere oltre, consentendo alla città di abbattere definitivamente le barriere portuali che ancora la privano della fruizione del suo mare, operando in coerenza con l’intervento che Ippodamo da Mileto progettò e realizzò nell’ Atene dell’età di Pericle , facendo sì che la città si congiungesse al suo porto (il Pireo), sia pure con gli strumenti che le circostanze imponevano: un muro protettivo che fisicamente ed istituzionalmente sancisse il diritto di reciproca appartenenza: città - mare .
Downloads

##submission.downloads##
Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).