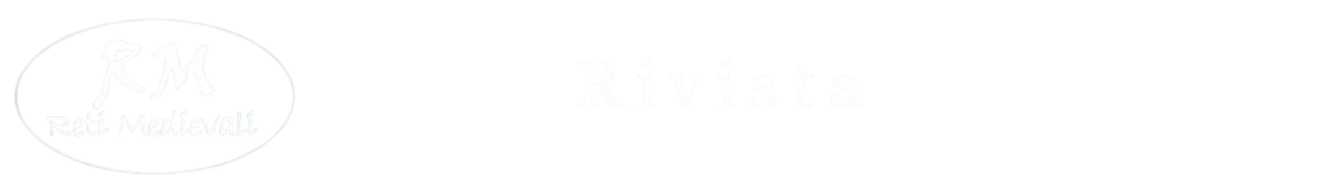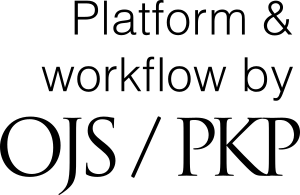«Ita quod arbor viva non remaneat»: devastazioni del territorio e prassi ossidionale nell’Italia dei comuni
DOI:
https://doi.org/10.6092/1593-2214/134Parole chiave:
Medioevo, XIII-XIV Secolo, Città comunale, AssedioAbstract
E’ noto come le devastazioni sistematiche del territorio e delle risorse economiche dell’avversario assumessero, durante i conflitti armati tra comuni dell’Italia centro settentrionale, un ruolo di primo piano. A dispetto di simile constatazione, tuttavia, la storiografia disponibile sull’argomento – fatte ovviamente le debite eccezioni – si limita a constatarne la presenza, o a sottolinearne la preponderanza delle occorrenze rispetto a diverse forme della prassi militare quali l’assedio e la battaglia, senza però formulare adeguati schemi interpretativi. Risultano allora talvolta dominanti, in un panorama di studi certo poco affollato, le lontane suggestioni di scritti in lingua inglese, e in particolare dell’Arte occidentale della guerra di Victor Davis Hanson, troppo distanti però, sia nel tempo sia nello spazio, dal medioevo delle città italiane, e dunque paradigmi da considerare con prudenza.
Il lavoro proposto ripercorre i temi sopra accennati, proponendo una nuova lettura di quanto sinora noto in materia per l’ambito comunale italiano. A partire dall'analisi delle devastazioni sistematiche si tenta quindi di mettere in luce una profonda ma sfuggente dinamica della prassi bellica operante nell'Italia delle città: considerando le coltivazioni di volta in volta distrutte dalle incursioni, il modo in cui esse venivano condotte, le truppe così impiegate e gli esiti concreti e psicologici di simili operazioni, ci si propone infine di evidenziare la stretta relazione esistente tra tale pratica e le operazioni di assedio propriamente intese.
Downloads
##submission.downloads##
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
RM Rivista pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
| CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.